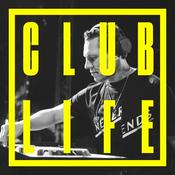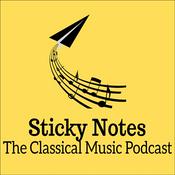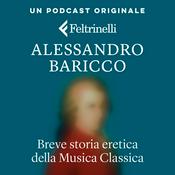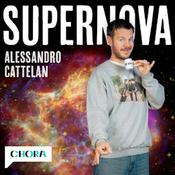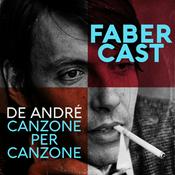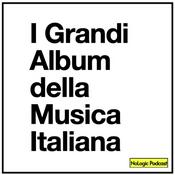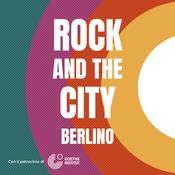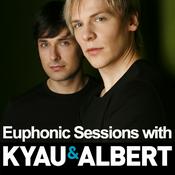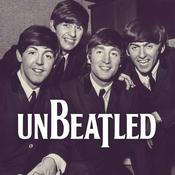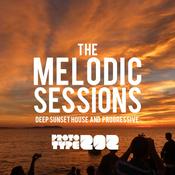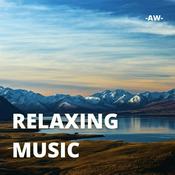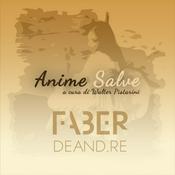8 episodi
- Dalla mia riva, da quel che vedo prima di riprendere il largo, da ciò che accade prima che il distacco diventi realtà concreta e mi porti via dalle certezze che ho creduto di possedere.
“D'a a me riva” (D’ä mæ riva) è il prezzo che paga il marinaio nel suo peregrinare, è la malinconia che cresce man mano che la riva gioca a nascondino con le onde, fino a scomparire dietro l'orizzonte.
Siamo partiti con Crêuza de mä e ci siamo allontanati sfidando ogni onda del Mediterraneo riconoscendo, nell’incertezza della navigazione, la sicurezza di ritrovarci simili coi nostri simili: nell’ipocrisia, nell’amore, nella voglia di andare e nel desiderio di tornare. Ora siamo alla fine di questo viaggio.
L’ultimo brano dell’album è un’ode al distacco, una canzone carica di suggestione e malinconia. L’uomo saluta la sua donna, la sua certezza e l’immagine del “pensarti controsole” rafforza il concetto del distacco, del guardare da lontano. Lei guarda “più al largo del dolore” mentre appunto ci si sposta verso il largo.
Dice De André nello speciale Mixer del 1984: “[Della] compagna della vita resta al marinaio soltanto una fotografia di quando lei era ragazza, una fotografia sbiadita in fondo ad un berretto nero, per poter baciare ancora Genova sull'immagine di una bocca che io definisco in naftalina".
Nell’intera canzone la musica passa in secondo piano, lasciando spazio all’emozione di un testo che racconta la realtà sognata e quella vissuta.
Fabrizio De Andrè suonerà infatti una chitarra ottava: piccola e con un suono decisamente caratteristico, sullo sfondo di un mare calmo ma tuttavia presente.
Nel raccontare quest’eterno peregrinare dei marinai, c’è comunque un’altra chiave di lettura secondo la quale Fabrizio parla di se stesso. In questo caso la riva sarebbe quella della Sardegna mentre dall’altra parte fa capolino Genova. Il baule da marinaio cantato negli ultimi versi apparterrebbe a lui stesso, magari preparato dalla madre Luisa, della quale trova una foto in giovane età.
De André sa bene di chi parte e di chi torna e sulla canzone si esprime così: “Quando un navigante abbandona la banchina del porto della città in cui vive, arriva il momento del distacco dalla sicurezza, dalle certezze, sotto specie magari di una moglie custode, appunto, del talamo nuziale, agitante un fazzoletto chiaro e lacrimato dalla riva. Il distacco dal pezzetto di giardino, dall’albero di limone e, se il navigante parte da Genova, sicuramente dal vaso di basilico, piantato lì sul balcone a far venire appetito agli altri, a quelli che restano, ai disertori del mare.”
-----------------
Curato da Lucia Lamboglia e con la voce di Simona Atzori.
Per la bibilografia cliccare qui: https://deand.re/podcast/creuza-de-ma/ - A Duménega è forse la canzone dell'intero album scritto in genovese, che meglio racchiude i temi più cari a De André: lo sguardo non giudicante nei confronti delle prostitute, degli ultimi associato al finto moralismo borghese e perbenista, altro aspetto dell'ipocrisia del potere. A Dumenega è, in un certo senso, la rivincita delle prostitute.
Dice De André presentando la canzone durante il concerto di Guidonia del 1991: “Nella mia splendida, amatissima, per quanto perfida città, tre o quattro secoli fa le prostitute erano relegate in un quartiere che si chiamava allora, come oggi, Rebecca. Veniva loro concesso di uscire da questa specie di recinto soltanto nei giorni di festa. Potete immaginare il popolaccio dire loro cose mostruose. […] ”
Nella Genova d’un tempo, infatti, si racconta di un’usanza secondo la quale le meretrici venivano relegate in un quartiere, Rebecca, per l'appunto, e che, attraverso il guadagno ottenuto, il comune riuscisse a pagare tutti i lavori portuali di un anno e a finanziare la costruzione di un nuovo molo.
E’ qui che è radicata l’ipocrisia che fa da filo conduttore lungo tutto il brano. La canzone è una fotografia del giorno di festa: la domenica.
Come esposto da De André, l’unico diritto inalienabile di queste donne, era infatti il rito della passeggiata domenicale, una sorta di processione laica in cui i membri della “nobile” borghesia genovese deridono, insultano, scherniscono ma soprattutto non si curano della coscienza sporca e dell’ipocrisia nascosta dietro quegli aggettivi urlati con l’unico scopo di denigrare.
Le stesse persone rappresentano infatti gli assidui frequentatori che durante i restanti giorni della settimana vanno “lì, al primo piano, a pregarle di maritare”.
Ce lo ricorda De André, ce l’aveva cantato già ne La Città Vecchia sottolineando così la differenza tra idea e azione:
"Quella che di giorno chiami con disprezzo specie di troia / Quella che di notte stabilisce il prezzo alla tua gioia.”
Non è la prima volta che nella produzione discografica di Fabrizio si intreccia l’amore sacro all’amor profano, quasi come a volerne cancellare il confine, tracciato poi chissà da chi.
Il brano si chiude con l’ennesimo insulto urlato dal sacrestano, il portatore della croce nelle cerimonie, il bigotto al quale la prostituta prontamente risponde: “Brutto stronzo d’un portatore di Cristo, non credere di essere l’unico che se n’è accorto, che in mezzo a quelle creature che si guadagnano il pane nudo c’è anche tua moglie!”
Si deve sottolineare, musicalmente, la presenza della chitarra andaulsa suonata da Franco Mussida, già chitarrista della Premiata Forneria Marconi, che dona la degna conclusione al brano in uno sfumato “quasi senza fine”.
-----------------
Curato da Lucia Lamboglia e con la voce di Simona Atzori.
Per la bibilografia cliccare qui: https://deand.re/podcast/creuza-de-ma/ - La cornice è ancora Genova e i colori usati per dipingere il quadro di Creuza de Ma sono sempre gli idiomi locali la cui bellezza, come ricorda lo stesso De André, è la loro mobilità.
Nell’antica repubblica marinara, la “Pittima” era la figura alla quale i cittadini si rivolgevano privatamente per far esigere i crediti dai pagatori insolventi. Per questo, ancora oggi, viene utilizzato lo stesso termine per descrivere una persona noiosa e pedante.
Anche stavolta, lo sguardo di De André non si posa sulla maggioranza o sulle maggioranze, ma scruta attento i motivi che si celano dietro questa scelta lavorativa. In questo caso, l’emarginazione sociale vissuta e sperimentata dal protagonista è dovuta alle carenze fisiche che vengono raccontate nella prima strofa della canzone. In realtà un vero e proprio aspetto sgradevole tale da apparentarlo allo iettatore napoletano, portatore di sfortune, agli occhi degli altri.
“Cosa ci posso fare se non ho le braccia per fare il marinaio / se in fondo alle braccia non ho le mani del muratore.”
A questo proposito va citata una canzone bretone del ‘400 che secondo alcuni rappresenta la fonte di ispirazione di tutta la vicenda.
“Io non andrò mai a pescare perché sono un po’ zoppo, questo non m’impedisce di amare il mare come i miei vecchi.”
A gettare maggior luce sulla figura è lo stesso Fabrizio che si esprime a riguardo dicendo: “Ho immaginato la mia Pittima come un uccello che non riesce ad aprire le ali ed è destinato a nutrirsi dei rifiuti dei volatili da cortile.”
La Pittima ricorda a se stesso e agli altri i motivi che l’hanno portato lì, puntando il dito contro la poca generosità riservatagli dalla natura. Un destino sgarbato che non concede sconti.
Eppure lavora operando in mezzo alla gente così da scuotere le coscienze facendo leva su un senso di vergogna. L’umanità viene fuori solo verso la fine del brano, quando la Pittima esprime la voglia di contribuire economicamente quando la situazione finanziaria del creditore si mostra disastrosa.
Musicalmente, ancora una volta, a dominare la scena ci sono gli strumenti etnici bouzuki e percussioni, con la presenza melodica dei fiati. Una musica che sa quasi di recupero della dignità del protagonista, nonostante il destino gli abbia riservato una vita da pittima.
-----------------
Curato da Lucia Lamboglia e con la voce di Simona Atzori.
Per la bibilografia cliccare qui: https://deand.re/podcast/creuza-de-ma/ - “E digli, a chi mi chiama rinnegato che a tutte le ricchezze e all’argento e all’oro Sinàn ha concesso di luccicare al sole bestemmiando Maometto al posto del Signore.”
E’ il 1944 quando De Andrè trova nella biblioteca del padre un libro dal titolo “Mediterraneo” che gli apre le porte sull’incredibile viaggio di Scipione Cicala, un marinaio genovese catturato dai musulmani.
Facciamo un passo indietro e troviamo Mauro Pagani di rientro da un viaggio di esplorazione nel Mediterraneo che consegna a Fabrizio la storia del rapimento di Miguel De Cervantes, rimasto per dieci anni in galera ad Algeri e liberato poi per intercessione del re di Spagna.
Il quarto brano di Creuza de Ma è un anello di congiunzione tra questi due eventi storici.
Nel 1560 Scipione e suo padre, il visconte Cicala, vengono rapiti e portati prima a Tripoli e poi a Instanbul. Il Visconte riesce a pagare il riscatto e viene liberato ma lo stesso destino non viene riservato al figlio, il quale si trova così di fronte al bivio che gli mostra la morte da un lato e la possibilità di rinunciare al cristianesimo per convertirsi all’Islam, dall’altro. Abbracciando la filosofia di chi non si oppone alla corrente, il Cicala decide di rinnegare la sua religione.
Quello che emerge è uno dei temi portanti più volte fatti trapelare dal cantautore genovese, quello dell'indulgenza.
La scelta dell’uomo è certamente legata all’opportunismo ma più per istinto di sopravvivenza che per reale volontà di assurgere alla figura di arrampicatore sociale o di rinnegato (rénegôu) se si guarda la vicenda dal punto di vista dei Cristiani.
Nel frattempo Scipione fa carriera: divenne silahtar, ossia guardia del corpo personale del Sultano Solimano il Magnifico, poi ağa, ossia comandante in capo del corpo stesso dei giannizzeri per poi diventare beylerbey, ossia governatore generale, della città di Van, e infine Visir della fortezza armena di Erevan.
Si distinse, inoltre, per una serie di scorribande piratesche nel Sud Italia salvando, inoltre, la vita a un bey, cioè un nobile ottomano. Ottenne così il titolo di “Sinàn Capudan Pascià” ovvero il genovese grande ammiraglio della flotta ottomana.
Sina, infatti, è etimologicamente legato a Zena, Genova, come la chiamano i suoi abitanti.
C’è un quartiere, a Instanbul, che porta il suo none: Cağaloğlu, poichè suffisso -oglu significa “figlio di”, ovverosia il figlio di Cicala (Ciga).
“In mezzo al mare c’è un pesce tondo che quando vede le brutte va sul fondo.In mezzo al mare c’è un pesce pallache quando vede le belle viene a galla.”
Un vecchio ritornello di origine popolare che apre e chiude il brano, emblema della vicenda di Scipione Cicala.
A livello strumentale va menzionato, tra gli altri, il synclavier, strumento elettronico nella sezione “archi”.
Come per Jamin-a, nella versione dell'album uscito nel 2014, esiste un remix alternativo all'originale, fino ad allora inedito.
-----------------
Curato da Lucia Lamboglia e con la voce di Simona Atzori.
Per la bibilografia cliccare qui: https://deand.re/podcast/creuza-de-ma/ - “La guerra è un’ossessione dei vecchi che mandano i giovani a combatterla”, scriveva Baricco, e nell’intera discografia di De Andrè troviamo spesso riferimenti in grado di riprendere questo concetto. ù
Da “Girotondo” a “La guerra di Piero”, il tema bellico non si è mai distanziato troppo dal pensiero di Fabrizio che ne ha cantato ogni conseguenza, descrivendone il tormento e la fatica.
In questo caso specifico ci troviamo in Libano, durante la drammatica guerra civile durata ben quindici anni. De Andrè punta il faro sul passaggio delle truppe israeliane a Sidone, tra il confine del Libano e Beirut e ne presenta il lavoro così: “Sidone è la città libanese che ci ha regalato, oltre all’uso delle lettere e dell’alfabeto, anche l’invenzione del vetro. Me la sono immaginata, dopo l’attacco subito dalle truppe del generale nel 1982, come un uomo arabo di mezz’età, sicuramente povero, che tiene in braccio il proprio figlio macinato dai cingoli di un carro armato. Un grumo di sangue, orecchie e denti da latte, ancora poco prima labbra grosse al sole, tumore dolce e benigno di sua madre, forse sua unica e insostituibile ricchezza.”
L’inizio del brano coincide con le voci dei presidenti Ronald Reagan e Ariel Sharon e con in sottofondo i cingoli di un carro armato. L’immagine descritta è quella di un padre che regge tra le braccia i resti del figlio, il più innocente che sconta l’egoismo esercitato dal potere. Un padre che piange e odia e in questo ciclico ripetersi di emozioni, si rafforza l’inutilità del conflitto bellico.
Continuando con l’ascolto del brano, conosciamo chi questa guerra la combatte: i soldati, descritti come cani arrabbiati con la schiuma alla bocca in cerca di agnelli.
Camminiamo ancora percorrendo la forza evocativa del testo e arriviamo a Sidone, con la sua superba eredità nascosta però dalle fiamme, offuscata dall’odio.
La “piccola morte” che viene cantata a questo punto del brano non è da intendersi come la morte di un bambino bensì va accolta come figura retorica dietro la quale si cela la fine civile e culturale di un piccolo paese.
Il finale di Sidun è solo strumentale, un sottofondo che richiama il lamento senza fine di un padre arabo in un teatro di numerosi massacri.
Un brano, Sidun, che può, a ben ragione, assumere il rango di emblema del concetto di universalità applicato ai contenuti, espressi in maniera più o meno costante, nelle canzoni di Fabrizio De André, se si considera la drammatica e, in apparenza, perenne contemporaneità dei temi affrontati, soprattutto nel caso di quelli “contro la guerra”.
-----------------
Curato da Lucia Lamboglia e con la voce di Simona Atzori.
Per la bibilografia cliccare qui: https://deand.re/podcast/creuza-de-ma/
Altri podcast di Musica
Podcast di tendenza in Musica
Su Creuza de mä, il podcast
Creuza de mä è un viaggio che non tutti possono affrontare: è introspezione, coraggio, audacia, fallimento, amore. Una navigazione che approda sui temi della passione e del viaggio e che testimonia la voglia di non avere confini. In questa sospensione tra realtà e sogno si sviluppa l’intreccio di sette brani e altrettanti protagonisti. E’ di queste vite che ci faremo carico in questo viaggio da compiere insieme.
Curato da Lucia Lamboglia e con la voce di Simona Atzori.
Per la bibilografia cliccare qui: https://faber.deand.re/podcast/creuza-de-ma/
Sito web del podcastAscolta Creuza de mä, il podcast, CineScore - Le Musiche nel Cinema e molti altri podcast da tutto il mondo con l’applicazione di radio.it

Scarica l'app gratuita radio.it
- Salva le radio e i podcast favoriti
- Streaming via Wi-Fi o Bluetooth
- Supporta Carplay & Android Auto
- Molte altre funzioni dell'app
Scarica l'app gratuita radio.it
- Salva le radio e i podcast favoriti
- Streaming via Wi-Fi o Bluetooth
- Supporta Carplay & Android Auto
- Molte altre funzioni dell'app
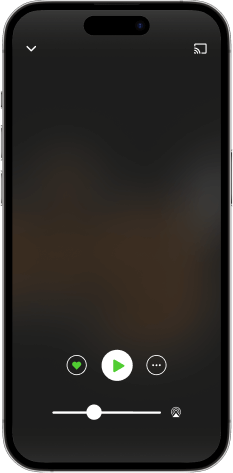

Creuza de mä, il podcast
Scansione il codice,
scarica l'app,
ascolta.
scarica l'app,
ascolta.